|
Editoriale
Approfondimenti
Notizie
Articoli
Le fabbriche del credere
di Andrea Camilleri
Biografia di Andrea Camilleri
Un sogno per fermare l'Aids
in Africa
di Claudia
Baldo, Irene Bertolucci,
Stefano Lusso, Giovanna Morelli, Francesco Sbrana
Sant’Egidio
e il progetto DREAM
Tre anni di cooperazione
Il piatto piange!
Il laboratorio di
Galileo Galilei
di Claudio Luperini
La missione di pace
di Pierino
di Andrea Addobbati
Le relazioni di Pedro
L'Università di Pisa
e la situazione italiana ed europea
di Luigi Russo
La percezione della
tecnologia: il caso dell'energia nucleare
di Walter Ambrosini, Giuseppe Forasassi, Marino
Mazzini, Francesco Oriolo, Giuseppe Pilonei
Ingegneria nucleare a
Pisa
di
Walter Ambrosini, Giuseppe Forasassi, Marino Mazzini, Francesco Oriolo,
Giuseppe Pilonei
Energia nucleare e pace
Il nucleare è un problema politico
L’umanista
e il bit
di Giuliana Guidotti STmoderna.it
Intervista a Elena Guarini Fasano
di Barbara Grossi

Scarica il PDF (1.2 Mb)
 |
Il
laboratorio di Galileo Galilei
Alle origini dello sperimentalismo
Ad aprile
2005 è stata allestita la mostra “L’Apparato Gravità e
il Laboratorio di Galileo Galilei” in una sala del Museo degli
Strumenti per il Calcolo nell’area dei Vecchi Macelli in occasione
dell’anno mondiale della Fisica. Nella stessa area erano presenti
altre due mostre: “I Microscopi della Fisica” e “La
Ludoteca Scientifica”.
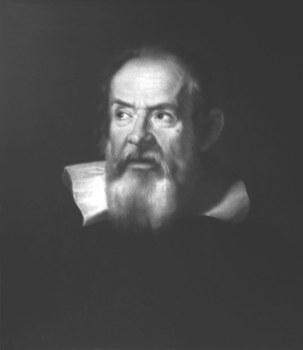 Le
manifestazioni, che si sono concluse il 17 maggio, sono state organizzate
dal dipartimento di Fisica “Enrico Fermi” dell’Università di
Pisa, dalla sezione pisana dell’Istituto nazionale di fisica nucleare,
dalla Fondazione Galileo Galilei e dall’Istituto per i processi
chimico-fisici del CNR. Le
manifestazioni, che si sono concluse il 17 maggio, sono state organizzate
dal dipartimento di Fisica “Enrico Fermi” dell’Università di
Pisa, dalla sezione pisana dell’Istituto nazionale di fisica nucleare,
dalla Fondazione Galileo Galilei e dall’Istituto per i processi
chimico-fisici del CNR.
La risposta del pubblico è stata notevole, soprattutto grazie alla
partecipazione delle scuole che hanno quasi esaurito le visite in gruppo
disponibili durante le mattine dal lunedì al venerdì.
Per una migliore fruizione delle tre mostre erano presenti numerosi studenti
dell’Università di Pisa che si sono alternati a fare da guida
scientifica ai visitatori.
Il Laboratorio di Galileo Galilei riesce a sfatare l’opinione, diffusa
soprattutto tra gli studiosi, che gli esperimenti di Galileo siano stati
solo mentali, sulla base di idee preconcette, quali l’arretratezza
degli strumenti di misura dell’epoca: Galileo, invece, ha realmente
fatto gli esperimenti avendo sia il genio per pensarli che gli strumenti
per realizzarli.
Ideato da Roberto Vergara Caffarelli, il Laboratorio è costituito
da strumenti, ricostruiti secondo le indicazioni e le descrizioni lasciate
da Galileo nei suoi scritti, che permettono la ripetizione degli esperimenti
del grande scienziato. Dall’analisi del funzionamento di tali strumenti è chiaro
che Galileo si era dotato di apparecchiature adatte alle proprie esperienze.
Ad esempio, per la misura del tempo, Galileo dapprima fa uso del pendolo,
dopo averne scoperto l’isocronismo, e poi inventa un altro strumento:
l’orologio ad acqua. Rispetto al pendolo, il nuovo apparato gli permette
una misura continua del tempo con la precisione del decimo di secondo. L’idea
geniale dell’orologio ad acqua fu quella di sfruttare uno strumento
di misura molto preciso già all’epoca di Galileo: la bilancia.
 Gli strumenti del Laboratorio di Galileo in esposizione erano: il grande
piano inclinato (lungo circa 7 metri), l’orologio ad acqua, l’apparecchiatura
per la dimostrazione della legge del piano inclinato, lo strumento per la
dimostrazione del teorema delle corde, il pulsilogium, una installazione
sperimentale con due pendoli e una grande bilancia per la realizzazione
dell’esperimento della percossa. Erano anche presenti, all’interno
di vetrine, una lampada del XVII secolo, per ricordare la scoperta dell’isocronismo
nel Duomo di Pisa, il facsimile del registro di battesimo con la segnatura
di quello dello scienziato, facsimili di lettere e di altri documenti galileiani. Gli strumenti del Laboratorio di Galileo in esposizione erano: il grande
piano inclinato (lungo circa 7 metri), l’orologio ad acqua, l’apparecchiatura
per la dimostrazione della legge del piano inclinato, lo strumento per la
dimostrazione del teorema delle corde, il pulsilogium, una installazione
sperimentale con due pendoli e una grande bilancia per la realizzazione
dell’esperimento della percossa. Erano anche presenti, all’interno
di vetrine, una lampada del XVII secolo, per ricordare la scoperta dell’isocronismo
nel Duomo di Pisa, il facsimile del registro di battesimo con la segnatura
di quello dello scienziato, facsimili di lettere e di altri documenti galileiani.
L’esperimento proposto con il piano inclinato, dotato di rivelatori
a riflessione collegati a campanelli per segnalare il passaggio di sfere
che scendono su di esso, è stato la verifica della legge dei numeri
dispari, ovvero che in un moto uniformemente accelerato lo spazio percorso
(con velocità iniziale nulla) è direttamente proporzionale
al quadrato del tempo impiegato a percorrerlo. Infatti, in un moto uniformemente
accelerato, con velocità iniziale nulla, dopo un intervallo di tempo
t1 si avrà come posizione s1 = kt12 (dove 2k è l’accelerazione
costante), dopo 2t1 si avrà s2 = k4t12 = kt12 + k3t12, dopo 3t1 si
avrà s3 = k9t12 = kt12 + k3t12 + k5t12, e quindi s2 - s1= k3t12 =
3s1, s3 - s2= k5t12 = 5s1, cioè i vari spazi percorsi (s1, s2 - s1,
s3 - s2) in successivi intervalli di tempo uguali (t1) stanno fra loro come
successivi numeri dispari.
 L’installazione dell’orologio ad acqua, corredata con una bilancia
elettronica, un orologio digitale e un software realizzato appositamente,
proponeva al visitatore il confronto fra la misura di Galileo ed una misura
moderna di tempo. L’esperimento era realizzabile dallo stesso visitatore,
che poteva seguire le istruzioni disponibili sul monitor. Una prima parte
consisteva nella taratura dell’orologio: inserire nel programma alcune
misure per determinare a quanto tempo corrispondeva la raccolta di una certa
massa d’acqua. Dopo questa taratura si passava all’esperimento
vero e proprio: misurare simultaneamente un breve intervallo di tempo con
l’orologio ad acqua e con un cronometro digitale. L’installazione dell’orologio ad acqua, corredata con una bilancia
elettronica, un orologio digitale e un software realizzato appositamente,
proponeva al visitatore il confronto fra la misura di Galileo ed una misura
moderna di tempo. L’esperimento era realizzabile dallo stesso visitatore,
che poteva seguire le istruzioni disponibili sul monitor. Una prima parte
consisteva nella taratura dell’orologio: inserire nel programma alcune
misure per determinare a quanto tempo corrispondeva la raccolta di una certa
massa d’acqua. Dopo questa taratura si passava all’esperimento
vero e proprio: misurare simultaneamente un breve intervallo di tempo con
l’orologio ad acqua e con un cronometro digitale.
I risultati dell’esperimento mostrano chiaramente la validità dell’invenzione
galileiana, rimasta inesplicabilmente senza seguito.
L’apparecchiatura per la dimostrazione della legge del piano inclinato
serve per dimostrare che la componente della forza peso che agisce lungo
un piano inclinato dipende dal seno dell’angolo che il piano forma
con l’orizzontale. Essendo un’apparecchiatura di piccole dimensioni
e abbastanza delicata era stata inserita, insieme al pulsilogium e alla
lampada, all’interno di una vetrina.
Lo strumento per la dimostrazione del teorema delle corde, ricostruito seguendo
il disegno di Carlo Alfonso Guadagni, illustra un’importante scoperta
di Galileo: i corpi impiegano lo stesso tempo a percorrere piani inclinati
le cui lunghezze e altezze sono proporzionali a quelle delle corde tracciate
dal punto più alto di una stessa circonferenza verticale (per altezza
della corda si intende la sua proiezione sul diametro verticale). Questo
strumento è costituito essenzialmente da una semicirconferenza di
legno verticale dal cui punto più alto scendono due fili di acciaio
inox lungo i quali possono scorrere due piccoli cilindretti di ottone. Questi
due fili - uno fisso verticale e l’altro mobile sulla semicirconferenza
- costituiscono le corde della circonferenza. L’esperimento consisteva
nel far partire i due cilindretti dal punto più alto e verificare,
attraverso due campanelli posti a fine corsa di ciascuno dei due fili, che
arrivassero simultaneamente.
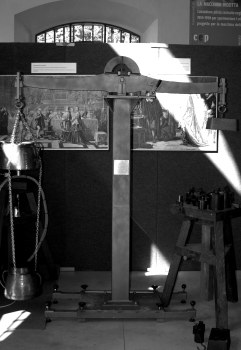 Il pulsilogium è un piccolo strumento che, sfruttando l’isocronismo
del pendolo, poteva essere usato dai medici per misurare la frequenza cardiaca. Il pulsilogium è un piccolo strumento che, sfruttando l’isocronismo
del pendolo, poteva essere usato dai medici per misurare la frequenza cardiaca.
L’installazione sperimentale con due pendoli permetteva di illustrare
in modo originale la conservazione dell’energia meccanica, grazie
anche alla presenza di laser inseriti nei pesi dei pendoli, e di misurare
il periodo dei pendoli di lunghezza opportuna, non solo contando direttamente
le oscillazioni, ma anche mediante rivelatori a infrarossi collegati ad
un computer e ad un programma software realizzato specificatamente.
La grande bilancia, alla quale era collegato un laser per poter valutare
meglio le oscillazioni, mostrava l’esperimento della percossa esattamente
come lo descrive Galileo. Il giogo della bilancia sostiene, da una parte,
due grandi secchie di rame, collegate insieme da tre catenelle, e dall’altra
i pesi. La secchia superiore ha un foro e un tappo posizionabile dall’interno.
L’esperimento consisteva nel riempire d’acqua la secchia superiore,
togliere il tappo e osservare le oscillazioni della bilancia mentre l’acqua
cadeva nella secchia inferiore.
Mi sembra opportuno far notare che le moderne attrezzature elettroniche,
che accompagnavano le apparecchiature, servivano solo a rendere più veloce
la ricostruzione dell’esperimento senza per questo snaturare la reale
procedura galileiana, della cui fattibilità lo spettatore si rendeva
conto facilmente.
Intorno agli strumenti del Laboratorio di Galileo erano esposte alcune stampe
ottocentesche (ingrandite) che proponevano vari momenti significativi della
vita del grande scienziato, e facsimili di documenti i cui originali sono
conservati a Pisa: accanto al registro con il battesimo di Galileo vi erano
le lettere autografe a Paolo Sarpi e a Guidobaldo Dal Monte, di grandissima
importanza scientifica e storica.
Alla mostra ha partecipato anche l’artista Vladimir Škoda con
la sua opera Galileo Galilei: un grande pendolo, fissato al soffitto, che
oscillava davanti ad uno specchio concavo poggiato a terra.
Al visitatore veniva proposto il calcolo della lunghezza del filo di questo
grande pendolo. Infatti, accanto all’opera di Škoda era disponibile
anche un piccolo pendolo lungo un metro, che si poteva far oscillare tenendolo
in mano. Confrontando i periodi di oscillazione del grande e piccolo pendolo
si poteva ricavare la lunghezza di quello grande tenendo presente la relazione
che lega la lunghezza e il periodo di un pendolo.
L’allestimento era completato da alcuni poster in cui erano riportate
sia le spiegazioni degli esperimenti in mostra, sia le citazioni galileiane
a riguardo.
Nella stessa sala del Laboratorio era presente anche “L’Apparato
Gravità”: realizzazione dell’esperimento pensato da Galileo,
in una versione attuale e di grandi dimensioni, che permette di verificare
l’universalità della legge di caduta dei gravi, e cioè che
nel vuoto tutti i corpi, anche i più leggeri, lasciati cadere insieme
dalla stessa altezza, arrivano a terra nello stesso momento. L’apparato,
ideato e progettato da Carlo Bemporad, Carlo Bradaschia, Marco Grassi e
Gianni Gennaro, è stato finanziato dall’Istituto nazionale
di fisica nucleare.
Claudio
Luperini
dipartimento
di Fisica "Enrico Fermi”
claudio.luperini@df.unipi.it
|

