|
Approfondimenti
Editoriale
Articoli
Notizie

Scarica il PDF (1.2 Mb)
 |
La corporate
governance nelle società quotate
Il caso italiano a confronto con Regno Unito e Stati Uniti
Il dipartimento
di Economia aziendale “Giannessi” dell’Università di
Pisa ha realizzato uno studio sui meccanismi di governance delle aziende
italiane, prendendo in esame tutte le società quotate nel nostro
paese, e li ha confrontati con quanto avviene in cento società straniere,
cinquanta inglesi e cinquanta statunitensi. Gli obiettivi erano quelli
di mettere a confronto sistemi di governo sottoposti a norme e pressioni
informative diverse e di individuare le variabili che influenzano le
scelte in tema di governance. La ricerca, di cui Athenet presenta un
estratto sintetico, è stata svolta dai professori Marco Allegrini
e Silvio Bianchi Martini e dai dottori Elena Bandettini e Giuseppe D’Onza.
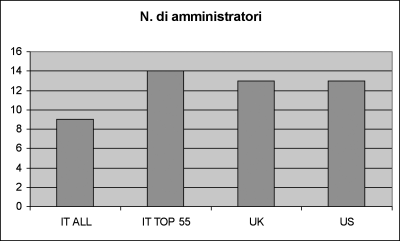 L’indagine
sulla corporate governance si è concentrata, in primo luogo, sul
consiglio di amministrazione, del quale sono state esaminate la composizione,
la strutturazione interna e l’attività espletata. Oltre a considerare
le caratteristiche dei membri che ne fanno parte (suddividendoli tra consiglieri
esecutivi, non esecutivi e ), sono stati analizzati i comitati istituiti
all’interno del consiglio e le attività svolte. Un altro aspetto
su cui è stata incentrata l’attenzione è rappresentato
dal sistema di controllo interno, del quale sono stati presi in considerazione
i diversi attori e l’attività da questi svolta: un particolare
approfondimento è stato dedicato sia al comitato di controllo interno
sia al collegio sindacale. Le fonti esaminate hanno compreso la documentazione
prodotta sul tema da parte delle aziende e pubblicata sui relativi siti
internet (relazioni annuali di corporate governance, statuti societari,
bilanci, report periodici e così via) e le schede riepilogative dell’attività di
controllo, che le aziende sono chiamate a produrre e a mettere a disposizione
annualmente alla CONSOB. L’indagine
sulla corporate governance si è concentrata, in primo luogo, sul
consiglio di amministrazione, del quale sono state esaminate la composizione,
la strutturazione interna e l’attività espletata. Oltre a considerare
le caratteristiche dei membri che ne fanno parte (suddividendoli tra consiglieri
esecutivi, non esecutivi e ), sono stati analizzati i comitati istituiti
all’interno del consiglio e le attività svolte. Un altro aspetto
su cui è stata incentrata l’attenzione è rappresentato
dal sistema di controllo interno, del quale sono stati presi in considerazione
i diversi attori e l’attività da questi svolta: un particolare
approfondimento è stato dedicato sia al comitato di controllo interno
sia al collegio sindacale. Le fonti esaminate hanno compreso la documentazione
prodotta sul tema da parte delle aziende e pubblicata sui relativi siti
internet (relazioni annuali di corporate governance, statuti societari,
bilanci, report periodici e così via) e le schede riepilogative dell’attività di
controllo, che le aziende sono chiamate a produrre e a mettere a disposizione
annualmente alla CONSOB.
Per quanto concerne il contesto italiano, dall’indagine è emerso
che, in base alle previsioni statutarie, i consigli di amministratori delle
aziende qui considerate dovrebbero essere composti, in media, da un numero
di membri oscillante tra 6 e 14; in effetti, gli organi amministrativi esaminati
risultano essere formati, in media, da 10 amministratori. Scendendo, poi,
nell’analisi dei singoli segmenti di Borsa, si nota che i consigli
più ampi sono quelli delle aziende appartenenti al Mib30 e al Midex
(nel grafico indicate come “IT TOP 55”) e, fra queste, risulta
evidente una netta disparità tra le realtà operanti nei settori
bancario ed assicurativo, da un lato, e quelle facenti parte di altri comparti
dall’altro: le prime, infatti, presentano, in media, un numero di
amministratori molto più elevato rispetto alle seconde (17 contro
12); quest’ultima differenza, peraltro, risulta essere presente anche
nell’ambito degli altri segmenti.
Per quanto concerne la figura del Presidente, in Italia nella maggioranza
dei casi è risultata essere separata rispetto a quella dell’Amministratore
Delegato, sebbene il Codice Preda non lo richieda. In alcune delle realtà esaminate,
peraltro, è evidente come anche se le due figure sopra menzionate
risultano formalmente separate, si tratta di cariche rivestite da persone
appartenenti alla stessa famiglia, nonché al gruppo di comando. Anche
in questo caso, dall’esame dei dati raccolti emergono rilevanti differenze
tra le aziende italiane: ben l’86% delle società appartenenti
al MIB 30, infatti, ha un Presidente distinto dall’Amministratore
Delegato, mentre nell’ambito del segmento Ordinario ciò si
verifica solo nel 52% dei casi.
Riguardo a questo aspetto, si rilevano notevoli differenze rispetto alle
altre realtà esaminate: in Gran Bretagna, infatti, la quasi totalità delle
aziende appartenenti al campione applica rigorosamente la divisione tra
il Presidente e l’Amministratore Delegato, così come, del resto, è richiesto
dal Combined Code; nel contesto statunitense, invece, è raro trovare
queste due cariche separate: nella stragrande maggioranza dei casi, risultano
essere, invece, ricoperte dalla stessa persona.
Per quanto riguarda l’indipendenza del Presidente, dai dati è emerso
che nella maggioranza delle aziende inglesi il Presidente è indipendente,
mentre sia in Italia sia negli Stati Uniti, ciò si verifica solo
raramente: in particolare, delle società americane esaminate, solo
3 hanno dichiarato di avere un Presidente indipendente.
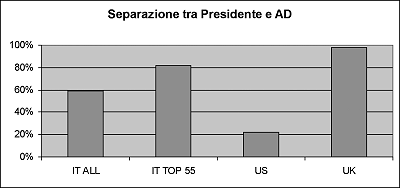 In merito alla composizione dell’organo amministrativo, dal confronto
tra i tre Paesi è risultato che i consigli di amministrazione statunitensi
presentano generalmente una più alta percentuale di amministratori
non esecutivi rispetto a quelli italiani e a quelli inglesi. Per quanto
concerne, poi, la presenza di consiglieri indipendenti, questa è più bassa
nel contesto italiano rispetto a quanto avviene negli altri due Paesi. Tuttavia
si rileva come, in Italia, la nomina di questa tipologia di amministratori
costituisca una “novità”, visto che in passato di solito
i membri del consiglio erano sempre soggetti legati al gruppo di comando
o al management. In merito alla composizione dell’organo amministrativo, dal confronto
tra i tre Paesi è risultato che i consigli di amministrazione statunitensi
presentano generalmente una più alta percentuale di amministratori
non esecutivi rispetto a quelli italiani e a quelli inglesi. Per quanto
concerne, poi, la presenza di consiglieri indipendenti, questa è più bassa
nel contesto italiano rispetto a quanto avviene negli altri due Paesi. Tuttavia
si rileva come, in Italia, la nomina di questa tipologia di amministratori
costituisca una “novità”, visto che in passato di solito
i membri del consiglio erano sempre soggetti legati al gruppo di comando
o al management.
In merito ai comitati interni al consiglio, nel contesto italiano, a differenza
di quanto avviene nelle aziende anglosassoni, si è rilevata una presenza
di quello per le proposte di nomina estremamente limitata (solo il 13% delle
aziende appartenenti al campione, infatti, ha dichiarato di averlo costituito).
Quelle che, invece, non lo hanno costituito hanno giustificato il loro comportamento
asserendo che la struttura della compagine sociale o la limitata ampiezza
del consiglio non lo rendevano necessario. Del resto, è doveroso
precisare che la costituzione di questo comitato non è espressamente
richiesta dal Codice Preda.
In merito alla remunerazione degli amministratori i dati raccolti mostrano
che in Italia il relativo comitato è stato costituito dal 68% delle
unità considerate, una percentuale, quindi, nettamente superiore
rispetto a quella del comitato per le proposte di nomina. Alcune differenze
emergono dal confronto tra le aziende in base al settore di appartenenza:
il comitato è stato infatti costituito dal 74% del comparto bancario
o assicurativo, mentre nelle altre realtà la percentuale scende al
66%. Anche in questo caso, peraltro, sono evidenti le differenze tra i tre
Paesi considerati: quasi tutte le aziende americane e la totalità di
quelle inglesi, infatti, hanno costituito tale comitato.
Per quanto concerne, in particolare, il sistema di controllo interno, fra
i vari sub-comitati del consiglio di amministrazione, il comitato per il
controllo interno costituisce quello avente una maggior diffusione nelle
società quotate, in quanto il 76% delle società analizzate
ha provveduto alla costituzione di tale comitato, anche se in taluni casi
(5%) alcuni dei suoi membri sono amministratori esecutivi. Dalla ricerca
emerge che l’audit committee è più frequente nelle società italiane
a maggior capitalizzazione e nelle società quotate presso il segmento
star e del nuovo mercato, in quanto in quest’ultimo caso la presenza
di tale comitato costituisce un requisito necessario per mantenere la qualifica
di star e di società del nuovo mercato. La maggior parte dei collegi
sindacali è composto da 3 sindaci (90,5%) mentre i restanti sono
composti da 5 membri. Dall’analisi si rileva che soltanto il 26% delle
società ha almeno un membro del collegio eletto dagli azionisti di
minoranza nel caso in cui l’organo sia composto da 3 membri o almeno
due sindaci qualora il collegio sia costituito da 5 componenti.
Oltre a ciò, i collegi sindacali presentano a volte, come detto,
componenti molto “impegnati”: basti pensare che 40 sindaci risultano
avere più di 50 incarichi in società quotate e non. Tra le
variabili che possono esercitare una certa influenza nelle scelte operate
in tema di corporate governance, in seguito ad un esame critico della letteratura
esistente sull’argomento, sono state individuate le possibili “determinanti”:
il settore e il Paese di appartenenza, la dimensione, la struttura finanziaria,
la redditività, la composizione della proprietà e l’ampiezza
del consiglio di amministrazione; con riferimento al contesto italiano,
inoltre, è stato anche considerato il segmento di quotazione. Come
si è visto, è proprio quest’ultimo, insieme al settore
di appartenenza, a rappresentare due degli elementi che maggiormente influenzano
le scelte di governance delle società italiane.
In estrema sintesi dalle indagini è emerso che:
-le società inglesi presentano, in genere, dei consigli di amministrazione
formati, in maggioranza, da membri indipendenti e da un amministratore delegato
distinto dal presidente; quest’ultimo, inoltre, il più delle
volte risulta essere indipendente; in generale, è risultata molto
elevata la presenza di tutti i comitati considerati (il comitato per le
nomine, il comitato per le remunerazioni ed il comitato per il controllo
interno);
-le società americane generalmente combinano le due figure di amministratore
delegato e di presidente in un’unica persona, ma si caratterizzano
per una presenza di amministratori non esecutivi ed indipendenti particolarmente
ampia; anche in questo caso, in generale, i comitati considerati sono stati
istituiti;
-le società italiane hanno spesso l’amministratore delegato
distinto dal presidente, ma sovente quest’ultima carica è rivestita,
specialmente nelle società non finanziarie, dal principale azionista
o da un manager dell’azienda; per quanto concerne i comitati, raramente è possibile
riscontrare la presenza del comitato per le nomine (anche a causa della
struttura della proprietà), mentre sono abbastanza diffusi quello
per le remunerazione e quello per il controllo interno, nonostante il Codice
Preda (che ne raccomanda l’istituzione) sia di recente emanazione.
Dai risultati emerge inoltre come le maggiori società italiane (in
particolare quelle appartenenti al MIB30 ed al MIDEX) e quelle appartenenti
ai settori bancario ed assicurativo si stiano avvicinando sempre più al
modello anglosassone (si pensi, ad esempio, ala separazione tra presidente
e amministratore delegato, alla presenza di amministratori non esecutivi
ed indipendenti, alla costituzione del comitato per le remunerazioni); al
contrario, quelle di più modeste dimensioni continuano a mantenersi
ancorate alle caratteristiche proprie del modello “made in Italy”.
Marco
Allegrini
docente
di Economia aziendale
allegrin@ec.unipi.it
|

