|
Editoriale
Approfondimenti
Notizie
Articoli
Le fabbriche del credere
di Andrea Camilleri
Biografia di Andrea Camilleri
Un sogno per fermare l'Aids
in Africa
di Claudia
Baldo, Irene Bertolucci,
Stefano Lusso, Giovanna Morelli, Francesco Sbrana
Sant’Egidio
e il progetto DREAM
Tre anni di cooperazione
Il piatto piange!
Il laboratorio di
Galileo Galilei
di Claudio Luperini
La missione di pace
di Pierino
di Andrea Addobbati
Le relazioni di Pedro
L'Università di Pisa
e la situazione italiana ed europea
di Luigi Russo
La percezione della
tecnologia: il caso dell'energia nucleare
di Walter Ambrosini, Giuseppe Forasassi, Marino
Mazzini, Francesco Oriolo, Giuseppe Pilonei
Ingegneria nucleare a
Pisa
di
Walter Ambrosini, Giuseppe Forasassi, Marino Mazzini, Francesco Oriolo,
Giuseppe Pilonei
Energia nucleare e pace
Il nucleare è un problema politico
L’umanista
e il bit
di Giuliana Guidotti STmoderna.it
Intervista a Elena Guarini Fasano
di Barbara Grossi

Scarica il PDF (1.2 Mb)
 |
L’umanista
e il bit
Nuovi strumenti di analisi linguistico-letteraria
Gli umanisti
oggi si avvalgono del mezzo informatico per effettuare le loro ricerche
con maggior comodità e guadagno di tempo. L’informatica
ha permesso di accostarsi al testo in modo più consapevole, svolgendo
indagini linguistiche e letterarie più accurate.
 In
occasione del convegno “Scienze umane, Storia e Informatica: ricerca
e didattica, esperienze e prospettive”, che si è tenuto all’Università di
Pisa il 28 e 29 Settembre, abbiamo intervistato il professore Mirko Tavoni,
docente di Lingua italiana e presidente del corso di laurea in Informatica
umanistica del nostro Ateneo, perché ci illustrasse il rapporto
informatica-scienze umane, con particolare attenzione all’importanza
del calcolatore come strumento di analisi linguistico-letteraria. In
occasione del convegno “Scienze umane, Storia e Informatica: ricerca
e didattica, esperienze e prospettive”, che si è tenuto all’Università di
Pisa il 28 e 29 Settembre, abbiamo intervistato il professore Mirko Tavoni,
docente di Lingua italiana e presidente del corso di laurea in Informatica
umanistica del nostro Ateneo, perché ci illustrasse il rapporto
informatica-scienze umane, con particolare attenzione all’importanza
del calcolatore come strumento di analisi linguistico-letteraria.
Il computer diventa oggi una fonte di informazione e uno strumento di comunicazione,
compiendo analisi molto rigorose e consentendo la padronanza di una documentazione
più estesa. Questo, ritiene il professor Tavoni, ha permesso di passare
dalla produzione di concordanze a stampa, cioè l’elenco delle
parole contenute in un testo che lo studioso avrebbe utilizzato per le sue
analisi linguistico-letterarie, alla fase più matura dei risultati
digitali dell’elaborazione. Il mezzo informatico svolge una funzione
importante sia nell’ambito linguistico che letterario: è utilizzato
per problemi di attribuzione testuale e per indagini linguistiche, cosa,
quest’ultima, che ha visto applicazioni industriali con importanti
ricadute economiche.
Il calcolatore consente di effettuare analisi stilometriche, indagini sinonimiche,
linguistiche e morfologiche: misura la lunghezza di parole e di frasi e
la frequenza d’uso di sinonimi, riconosce la funzione sintattica di
vocaboli, segmenta il testo in unità di costituenti non ricorsive
e identifica gruppi di parole semanticamente coese. Rende inoltre possibili
analisi più profonde delle strutture documentarie, ricavando associazioni
rilevanti basate non solo sulla semplice distribuzione delle occorrenze
di parole, ma anche su correlazioni semantico-concettuali o sull’analisi
avanzata della struttura sintattico-testuale.
Si può dunque parlare di una “matematicizzazione” dell’ambito
umanistico, operazione che consiste nell’approntare e ordinare una
grande quantità di dati e nello studiare il testo in modo statistico. “Statistica
non significa contare i fenomeni, ma saperli elaborare secondo delle griglie
concettuali. Statistica non è un rozzo trattamento di dati, ma appartiene
ad un livello superiore”, afferma Tavoni.
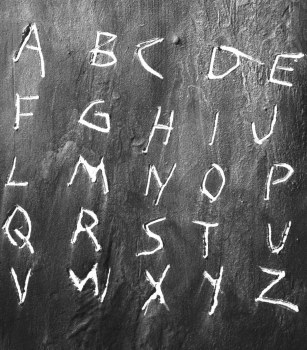 Si entra ora nella dimensione della web intelligence, dell’accesso
intelligente: si effettuano ricerche di contenuti nel web che non siano
meccanicamente espressi su stringhe di carattere: Google ad esempio ci offre
risultati straordinari poiché opera in modo meccanico e ricorre ad
artifici interni di tipo intelligente. Si estrae conoscenza da un’enorme
quantità di dati, mediante operazioni di data mining, web mining,
text mining che estrapolano informazioni dal testo in modo intelligente. Si entra ora nella dimensione della web intelligence, dell’accesso
intelligente: si effettuano ricerche di contenuti nel web che non siano
meccanicamente espressi su stringhe di carattere: Google ad esempio ci offre
risultati straordinari poiché opera in modo meccanico e ricorre ad
artifici interni di tipo intelligente. Si estrae conoscenza da un’enorme
quantità di dati, mediante operazioni di data mining, web mining,
text mining che estrapolano informazioni dal testo in modo intelligente.
Il computer diventa uno strumento filologico, permette di osservare gli “strati
compositivi” di un’opera e di comparare testi e relative stesure,
come “I Ricordi” di Guicciardini, la “Vita Nova” di
Dante o “Il Cortigiano” di Castiglione: il testo informatico è un
ipertesto, ovvero un documento di partenza a cui sono collegati altri documenti
mediante legami (links) definiti in vario modo dall’autore. “L’ipertesto
non ucciderà il libro tradizionale”, spiega Tavoni, poiché esso
non corre il rischio di essere soppiantato dalla comunicazione digitale;
esempio banale è l’esplosione delle e-mail che ha determinato
un aumento delle comunicazioni postali e non una diminuzione delle stesse.
Se da un lato l’autenticità del testo in rete è problematica,
non essendo garantita come nelle edizioni a stampa dal testo stesso, dall’altro
si garantisce un approccio linguistico-letterario più oggettivo,
offrendo una molteplicità di punti di vista.
Pertanto, nelle edizioni cartacee il filologo aveva la responsabilità intellettuale
di selezionare un testo, “un vincolo, ma anche un vantaggio”,
secondo il professor Tavoni, poiché doveva rispettare i limiti di
spazio della pagina stampa e garantiva con la sua scelta un “valore
aggiunto”, mentre nel web lo spazio è illimitato e si possono
analizzare simultaneamente più edizioni critiche.
L’umanista può effettuare una vasta gamma di analisi con maggior
comodità e guadagno di tempo, e per tale motivo deve aprirsi tecnicamente
e culturalmente al trattamento dell’informazione e alle tecnologie
della comunicazione, allo stesso tempo l’informatico, disponibile
ad un confronto intellettuale, compie un parallelo gesto di apertura nei
confronti dell’umanista.
Mirko Tavoni ribadisce che l’umanista necessita del computer, in quanto
potente mezzo di ricerca e di verifica, e l’informatico desidera confrontarsi
con i problemi degli umanisti; da questa sinergia nasce una nuova figura,
l’informatico umanista e la relativa scienza, l’informatica
umanistica, che nutre l’ambizione di portare gli studiosi di entrambe
le parti a dialogare.
Gli umanisti e gli informatici mirano, infatti, a rappresentare il campo
del sapere, problema ontologico in cui la conoscenza dei contenuti, la capacità di
formalizzare questa conoscenza e l’uso della tecnologia informatica è un
unicum che rappresenta un progresso intellettuale.
In conclusione, l’umanista possiede oggi un sapere tecnologico, padroneggiando
una progettazione di tipo informatico, “non uno strumento - secondo
il professor Tavoni - ma una cultura che tradizionalmente non gli appartiene”,
e mediante tale mezzo è in grado di accostarsi al testo in modo più consapevole,
effettuando accurate analisi sinonimiche, morfologiche, stilometriche e
linguistiche.
I campi di applicazione del calcolatore sono dunque il settore tecnico-informatico,
elemento necessario per effettuare analisi linguistico-letterarie, e gli
ambiti umanistico e linguistico, che infine hanno permesso di affrontare
i problemi relativi alla traduzione automatica, ovvero la capacità di
produrre, mediante il computer, un testo in un dato linguaggio naturale
a partire da un testo in linguaggio differente.
Giuliana
Guidotti
|

